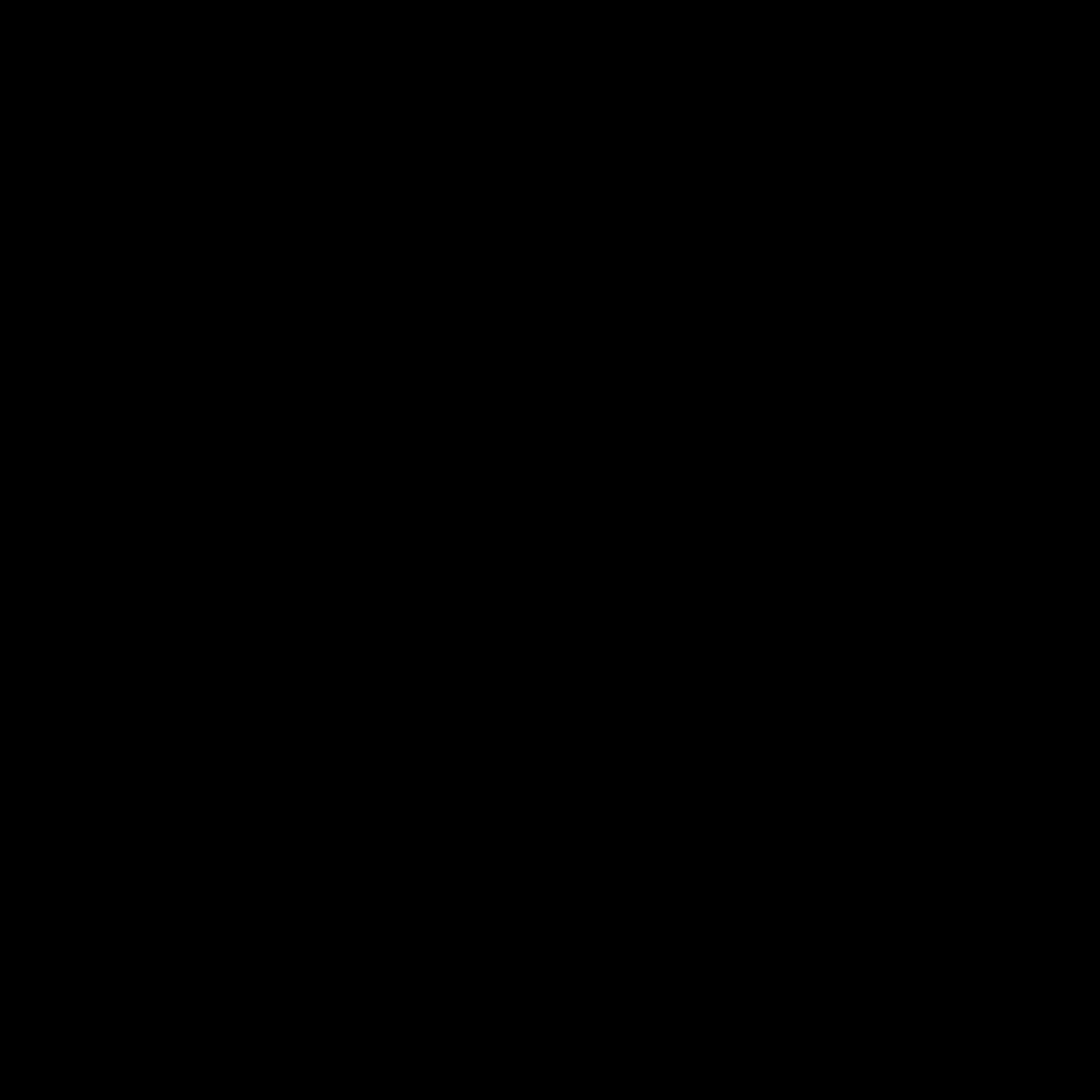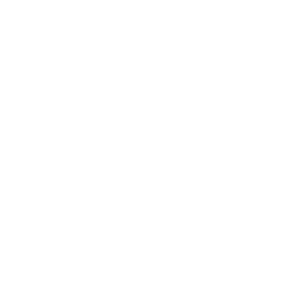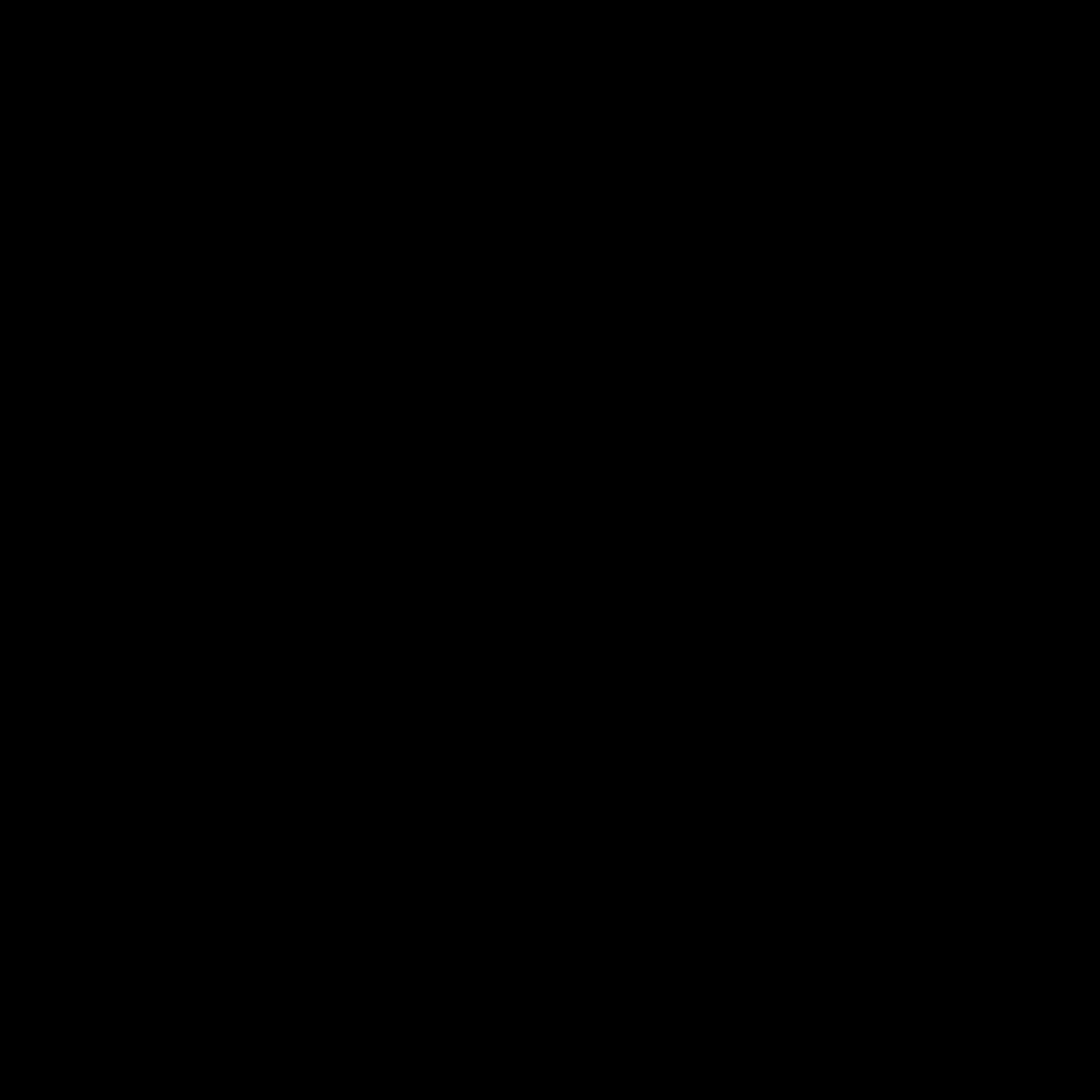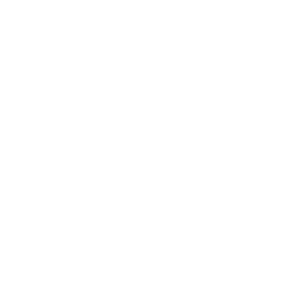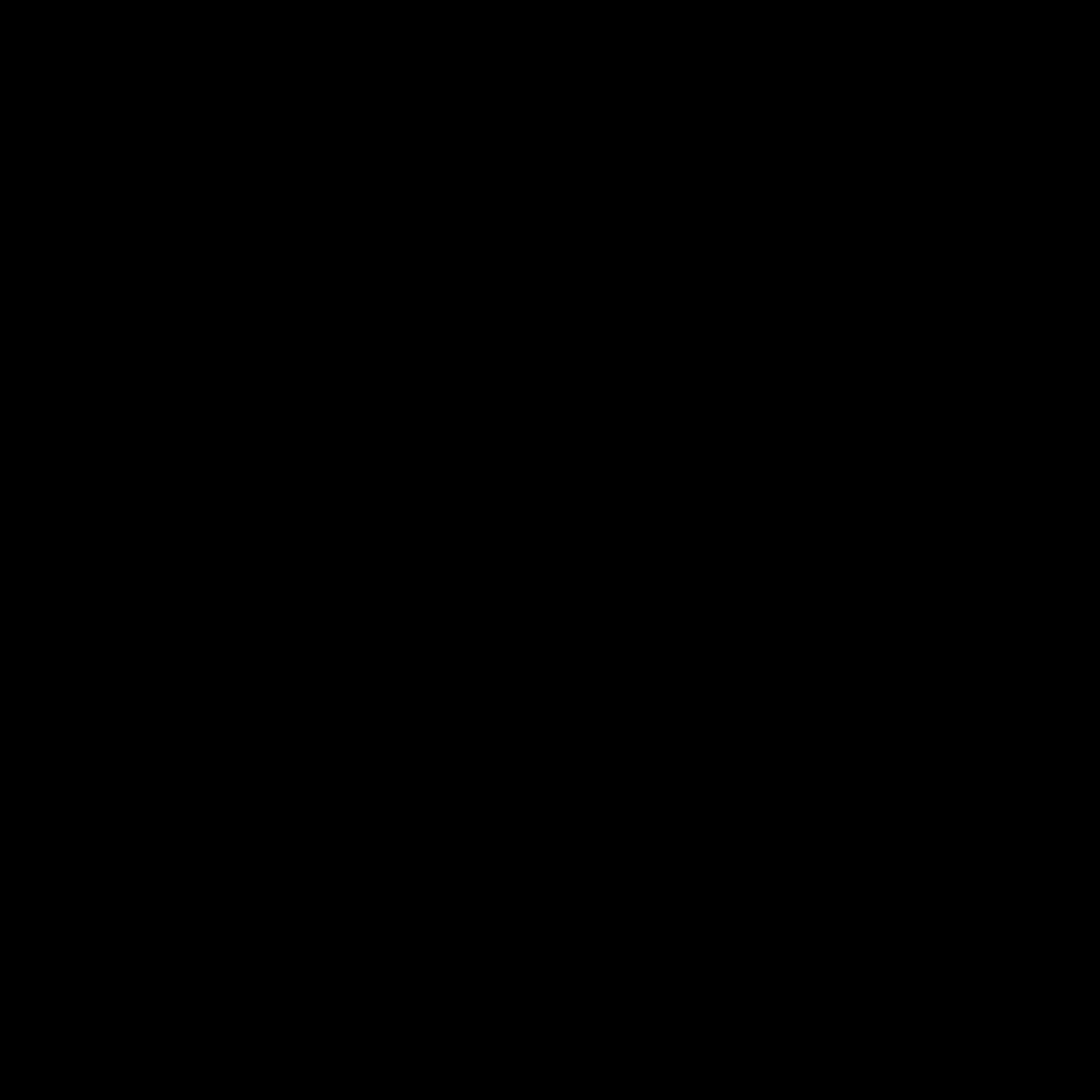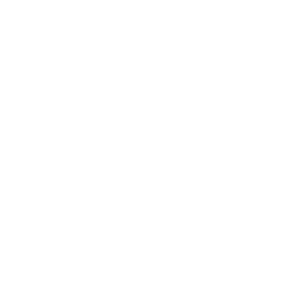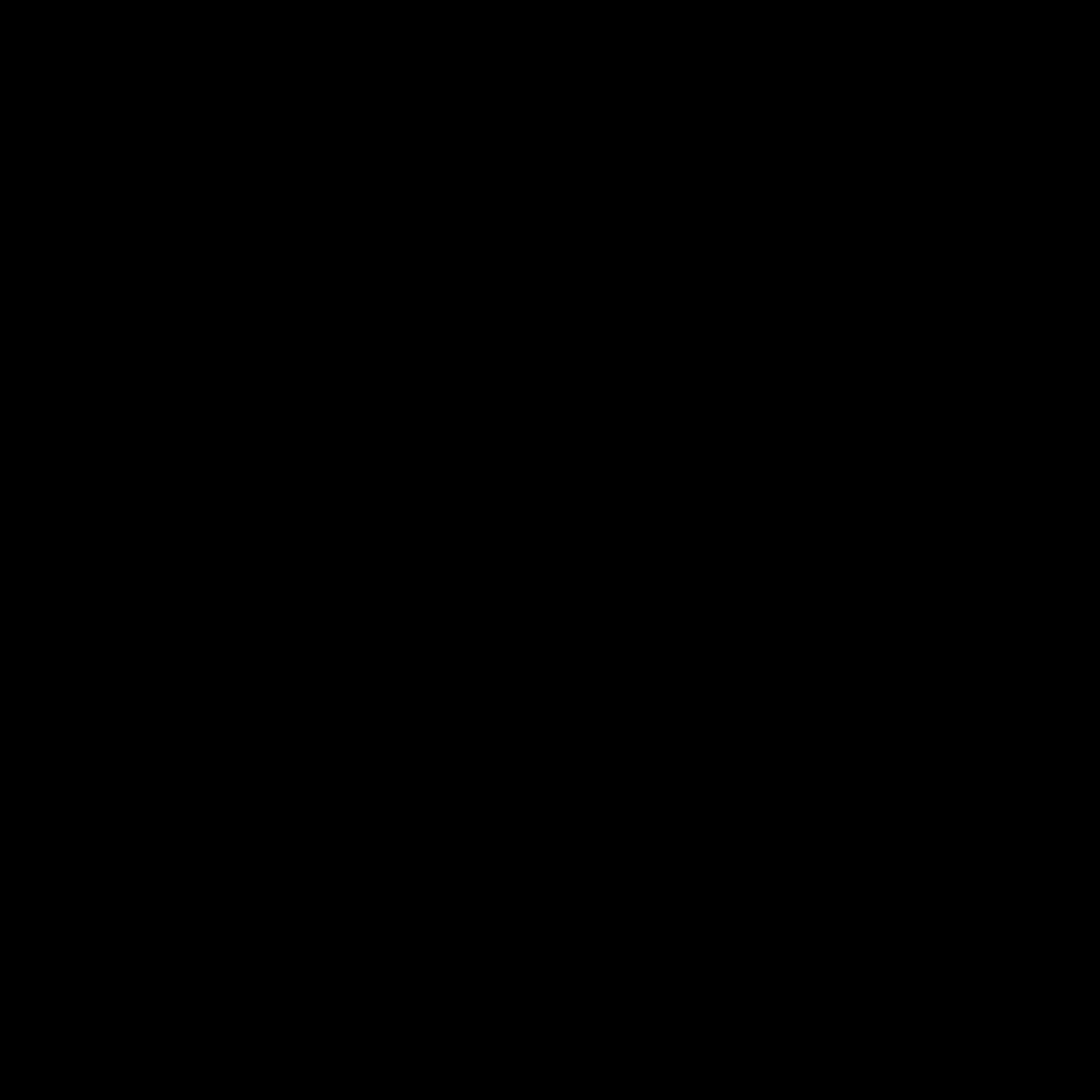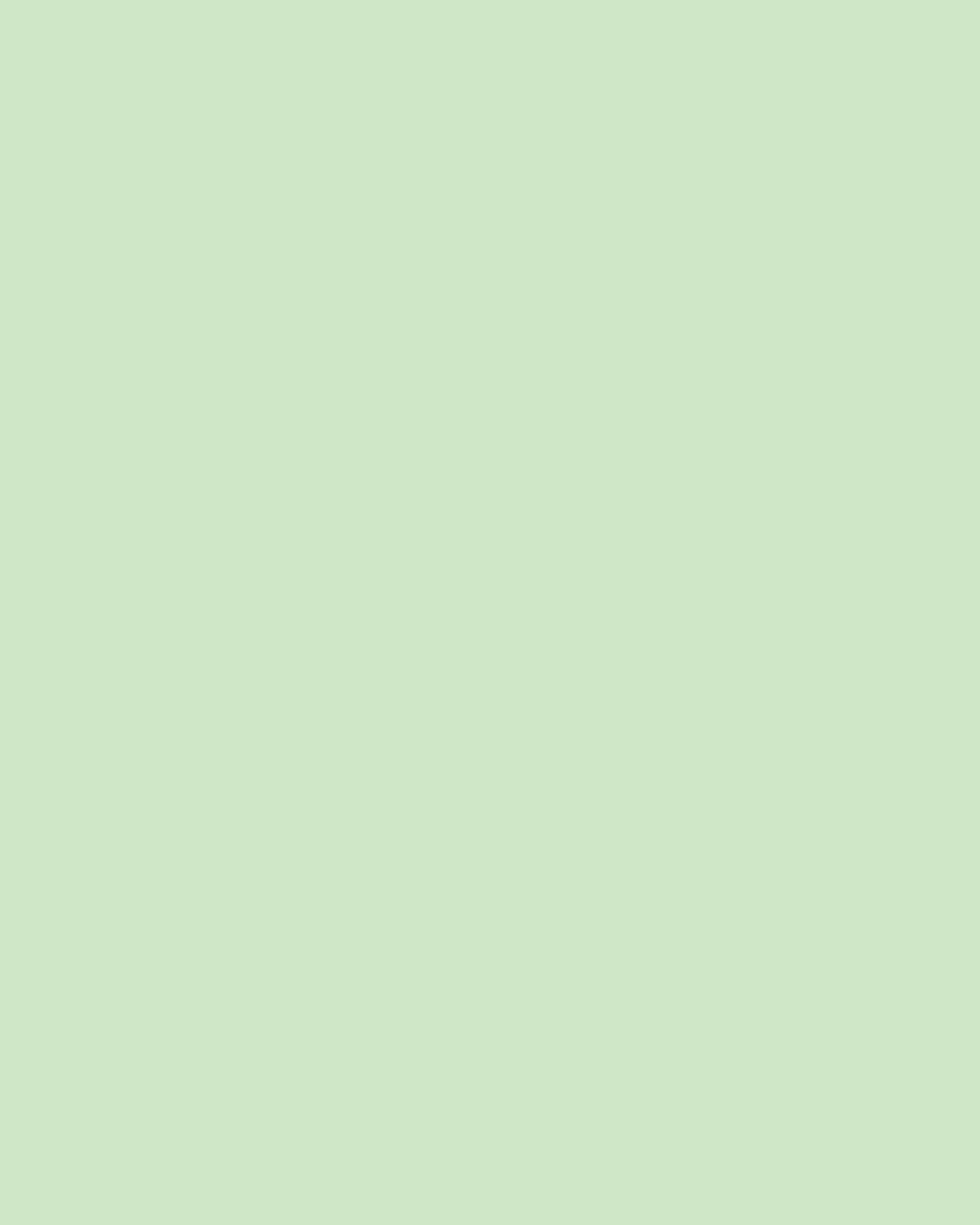Il primo scenario è quello della conservazione, che di solito si verifica quando i fondatori, o i loro eredi, sono ancora attivi in azienda. Una presenza fondamentale sul versante della coerenza, che talvolta rallenta l’innovazione. In Italia questo atteggiamento è piuttosto comune. Nella moda e non, tendiamo ad avere un approccio museale e conservativo: davanti a un bel palazzo antico facciamo magari un piccolo intervento di ristrutturazione, ma in generale pensiamo che sia meglio non toccarlo, lasciarlo così com’è. La stessa cosa accade in alcune aziende, che una volta individuate delle icone procedono senza inventare nuovi codici e linguaggi, forti solo della propria storia. Storia che di fatto resta chiusa in un cassetto, perché ci si dimentica che la memoria non è qualcosa di solido, ma cambia continuamente. È un territorio immenso, che include tante cose diverse, ed è necessario conoscerle per decidere cosa usare e cosa no, cosa è interessante dal punto di vista simbolico e cosa no.
Da qui, il secondo scenario, che dà anche il nome al mio intervento: la distruzione. Immaginiamo il brand come una perfetta sfera di marmo: se cominciamo a colpirla con uno scalpello, si aprirà in due, poi in quattro, poi in mille pezzi. Ma è quando il marchio è in frantumi che siamo capaci di guardarci dentro, di prendere i singoli pezzi e risignificarli. Certo, la sfera di marmo non c’è più, ma abbiamo moltissime nuove pietre straordinarie, da usare in tanti modi diversi. Io credo che dei brand, dopo averli conosciuti, non si debba avere nessuna pietà. I marchi possono, e forse devono, essere calpestati, anche se naturalmente resta fondamentale tenerli legati alla propria storia. Solo così l’eredità può essere usata in modo aperto, dinamico, e perfino disruptive.